Il male minore
corriere della sera 12/5/13
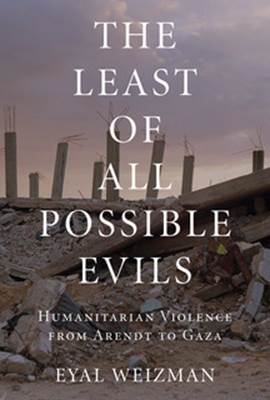 La moralità del numero ventinove. È su quel numero che si arrovella Eyal Weizman. Perché 29? Perché ci si può stringere nelle spalle, come di fronte a una dolorosa necessità, se 29 innocenti diventano il prezzo massimo, ma plausibile, da pagare al successo di un’operazione bellica o antiterrorismo? E chi è il delegato da Dio a fissare l’asticella del «minore dei mali possibili»? S’intitola proprio così, l’ultimo saggio arrivato nelle librerie italiane dello scrittore, filosofo, architetto israeliano, residente a Londra, Eyal Weizman: Il minore dei mali possibili (Nottetempo), quella minimizzazione dei danni collaterali che rende gli stessi danni moralmente ammissibili, commisurati, perfino giusti. O quantomeno giustificati dal fine e dal risultato eventualmente raggiunto.
La moralità del numero ventinove. È su quel numero che si arrovella Eyal Weizman. Perché 29? Perché ci si può stringere nelle spalle, come di fronte a una dolorosa necessità, se 29 innocenti diventano il prezzo massimo, ma plausibile, da pagare al successo di un’operazione bellica o antiterrorismo? E chi è il delegato da Dio a fissare l’asticella del «minore dei mali possibili»? S’intitola proprio così, l’ultimo saggio arrivato nelle librerie italiane dello scrittore, filosofo, architetto israeliano, residente a Londra, Eyal Weizman: Il minore dei mali possibili (Nottetempo), quella minimizzazione dei danni collaterali che rende gli stessi danni moralmente ammissibili, commisurati, perfino giusti. O quantomeno giustificati dal fine e dal risultato eventualmente raggiunto.
Ventinove civili, gli ha spiegato un giorno il controverso analista militare statunitenseMarc Garlasco, rappresentavano durante la guerra in Iraq la soglia di vittime incolpevoli ammesse nel corso di un omicidio mirato, senza la previa autorizzazione del presidente George W. Bush.
Quando l’intelligence statunitense individuava il nascondiglio di un nemico importante in un edificio residenziale, gli algoritmi di un apposito software calcolavano in base ai fattori ambientali, ai materiali di costruzione del palazzo, alla densità di abitanti, al tipo e alla quantità di esplosivo da utilizzare, il numero di persone che sarebbero state purtroppo uccise con lui: da trenta in su, occorreva come minimo il benestare del segretario alla Difesa, Donald Rumsfeld, in persona. Perché, per i legali militari americani, si varcava in tal caso il confine tra «sacrificio necessario» e «uccisione illegale».
Ma a volte i civili morivano e il bersaglio si salvava, perché era altrove, come accadde con Saddam Hussein e con «Alì il Chimico»: «Nelle prime fasi della guerra — rileva Weizman — i cinquanta bombardamenti mirati non riuscirono a eliminare gli obiettivi previsti, ma ciascuno di essi uccise un numero di civili prossimo al livello consentito — il livello proporzionale». I conti non tornavano, ma pochi se ne accorsero.
Non sono solamente i cinici e i senza cuore a relativizzare il valore della vita, dei beni e della sofferenza altrui. Né i professionisti delle tattiche militari e dei bilanci strategici. Di fronte a un’angosciosa «scelta di Sophie», ci sono anche gli operatori umanitari, i medici in zone di guerra, di catastrofi o di carestie, impegnati a calcolare la proporzione più equa tra il sacrificio di alcuni per la salvezza di altri, quando sarebbe impossibile assistere tutti: «Il soccorso umanitario può divenire letale per le stesse persone a cui è diretto — scrive l’autore —, una realtà registrata nelle statistiche epidemiologiche comparative e in quelle sui tassi di mortalità».
Eyal Weizman dischiude diversi scenari, laboratori dove la morale occidentale esercita o ha esercitato la sua pragmatica contabilità sul «male minore», dall’Etiopia a Gaza, dall’Iraq all’Afghanistan. Si sofferma sull’ambiente, sulle costruzioni e sulle demolizioni pianificate, in generale su quel panorama che si trasforma in un eloquente testimone d’accusa agli occhi di un «architetto forense», qual è lui, cofondatore del collettivo di Architettura della decolonizzazione (Daar), a Beit Sahour, in Cisgiordania.
Nato 43 anni fa ad Haifa, autore di altri volumi già tradotti in italiano, come Architettura dell’occupazione e Il male minore, Weizman sarà al Salone del libro di Torino, domenica 19 (ore 14.30, in Sala Azzurra), per presentare Il minore dei mali possibili con l’ex giudice della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, in un incontro moderato da Luca Molinari.
Di che cosa tratta, in definitiva, il suo libro? Di filosofia? Diritto umanitario? Politica? Storia? Architettura? Morale?
«Il libro nasce da una serie di brevi investigazioni filosofiche rivisitate attraverso un approccio misto, che passa per l’architettura, la storia, la giurisprudenza, il diritto internazionale e la filosofia. Ma soprattutto attraverso uno studio dei nuovi metodi dei governi che agiscono in situazioni neocoloniali, come in Afghanistan, in Iraq, in Palestina. A Gaza, per esempio, dove Israele esercita simultaneamente un controllo militare e un aiuto umanitario».
Un nuovo tipo di guerra fredda?
«Prima distruggi, poi ricostruisci. Ma secondo una tecnica precisa. Basta esaminare l’architettura dei campi profughi, le modalità dell’assedio di Gaza, il dosaggio degli approvvigiona-menti dei quali Israele autorizza di volta in volta l’ingresso nella Striscia. Quella paradossale alternanza tra ferocia e compassione, che non esisteva ai tempi delle colonie classiche».
Forse perché all’epoca non esisteva un problema di immagine internazionale.
«Già. Ai tempi dell’Impero britannico gli inglesi non avevano il concetto di vergogna. Oggi Israele fa quello che facevano i regimi coloniali tradizionali. Inoltre distrugge le prove delle sue distruzioni, per arrivare a negarle».
E la lotta al terrorismo? Nel film-documentario «The Gatekeepers», sei ex capi dello Shin Bet, i servizi segreti interni israeliani, raccontano proprio la difficoltà di scegliere fra mancare un colpevole, che magari sta preparando una strage, ed eliminarlo con un missile assieme a un manipolo di sfortunati passanti nei paraggi.
«Quando qualcuno ti dice di scegliere tra due opzioni, questa persona sta controllando le tue decisioni, sta orientando la tua volontà. C’è sempre una terza via. Non accetto la logica degli omicidi mirati e dell’ineluttabilità delle vittime collaterali. La violenza di Stato, una violenza fredda, fa parte di una forma di economia non finanziaria».
Quella che lei definisce «necroeconomia»?
«Esatto. Quando non puoi espandere la questione, devi rompere quell’economia. Perché il numero magico durante gli attacchi in Iran è stato il 30? Per i civili, questo numero indicava una soglia potenziale tra la vita e la morte. Ci si potrebbe chiedere come mai non 31 o 14, o 10. Ma è una domanda sbagliata. Io non voglio nemmeno discuterne, perché la gente che fa questi calcoli è gente che vuole essere libera di uccidere».
Ma se il minore dei mali possibili corrispondesse a tutto il meglio realisticamente possibile?
«Questo è il punto. Quando si trasferisce questo concetto dal piano teologico a quello politico si finisce per fraintendere gli argomenti originali di Sant’Agostino. I liberali l’hanno interpretato come un principio di ottimizzazione. Ma per un rivoluzionario il tuo meglio non è mai abbastanza buono».
Può indicare il caso più recente al mondo in cui si è agito in nome del minore dei mali possibili?
«In Pakistan, con gli attacchi dei droni americani. Una ricerca delle Nazioni Unite ha stabilito che è il Paese in cui ci sono state più vittime senza che sia stata dichiarata alcuna guerra».
E in Europa?
«In Italia, senza dubbio. Il male minore dovrebbe essere il suo motto sulla bandiera, magari scritto in latino. Il sistema di governo è basato sul compromesso, e perfino il Vaticano ha appoggiato Silvio Berlusconi come un male minore per proteggere i valori cristiani. Ma anche la Grecia, quando si è piegata all’Unione Europea e ne ha accettato la logica economica secondo la quale se non liberalizzi avrai ancora più problemi. Così in tempo di crisi si sacrificano i poveri, perché è questo il male minore».
Elisabetta Rosaspina

